(Il testo, completo delle note qui omesse, può essere scaricato da qui)
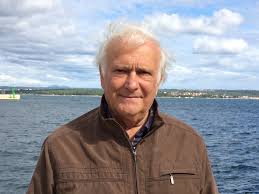 Carlo Minnaja
Carlo Minnaja
Accademia Internazionale delle Scienze San Marino
Università di Padova
Università “Lucian Blaga”, Sibiu (RO)
Treviso, 21 marzo 2007
1. Il problema linguistico nelle relazioni internazionali
Nella storia dell’uomo, da quando due tribù di lingue diverse sono venute a trovarsi in un contatto di qualsiasi genere, le barriere linguistiche sono state sentite come uno dei principali ostacoli alle relazioni reciproche. Lasciando da parte la forma primitiva di comunicazione a gesti, che peraltro ancora adesso non è del tutto scomparsa, quando la comunicazione con mezzo linguistico è insufficiente, nelle varie epoche, sotto l’influsso di fattori politici e culturali, una lingua o un’altra sono state usate nelle relazioni ufficiali come lingua franca.
A questo proposito, una parentesi: lingua franca è la corruzione dell’arabo lisan al-farang o lisan al-ifrang, termine con il quale gli arabi designavano la lingua degli europei; infatti essi chiamavano Farangia l’intera Europa occidentale, esclusa la Grecia. Con questo nome poi fu indicata, indipendentemente, la lingua di base con la quale si intendevano i soldati delle Crociate, provenienti da paesi diversi, ma in larga parte Franchi. Il termine indicò poi una lingua usata per molti secoli nel bacino del Mediterraneo per le relazioni tra europei, arabi e turchi, con radici lessicali prevalentemente italiane e spagnole e qualche radice araba, con una grammatica estremamente semplificata. Sopravvive nel sabir, lingua usata a lungo nel commercio mediterraneo e su navi con equipaggi misti (dallo spagnolo saber, conoscere).
Lingua franca per estensione venne ad indicare una lingua di comunicazione, dapprima elementare, poi anche più elaborata, ma non etnica, usata da popoli di lingue diverse, fino ad includere con questo termine anche le lingue creole, specialmente con riferimento al loro lessico misto. La lingua franca è dunque un rimedio ausiliario per la comunicazione tra persone di diverse lingue o dialetti.
Tralasciando la classificazione (o le classificazioni) che diversificano, a volte con criteri molto discutibili, le lingue dai dialetti o dalle parlate locali, possiamo dire che il cinese mandarino assolve il compito di lingua franca tra cinesi di regioni diverse, o che la greca κοινή, basata principalmente sui dialetti ionico e attico, diventò sotto Alessandro Magno la lingua comune dei territori conquistati dai suoi eserciti. Diventò poi una lingua ausiliaria comune in molte altre province dall’Asia al Nordafrica, dalle coste dell’Egitto a quelle del Mar Nero, fino a diventare la lingua ufficiale dell’impero di Bisanzio.
A sua volta il latino, sostenuto dalle legioni romane, diventò la lingua ufficiale dell’immenso impero, la lingua dell’esercito, dell’amministrazione, della legge, della cultura e del commercio. Si estese largamente anche nella parte orientale del Mediterraneo, pur rimanendo in quelle regioni il greco come lingua di base, greco che riprese il suo posto di lingua ufficiale al dividersi dell’impero romano in due tronconi, quello d’Oriente e quello d’Occidente. Si può notare che attualmente i greci non considerano l’impero bizantino come una parte del diviso impero romano resasi progressivamente autonoma, bensì un impero greco per lingua e per cultura.
Il tramonto del latino iniziò con il crollo dell’impero romano d’Occidente, ma fu un tramonto che durò quattordici secoli.
Il latino medievale rimase ancora come lingua comune delle classi privilegiate dell’Europa feudale: era la lingua dei nobili, della scienza, della cultura, della chiesa e della diplomazia. I regnanti erano bilingui, nonostante fossero spesso analfabeti. Il maggiore o minore successo di una lingua nel suo uso extra-nazionale è sempre stato dovuto a forze economiche e militari, senza alcuna relazione alla struttura interna della lingua stessa. In linea di principio ogni lingua può giocare un tale ruolo di egemonia o essere rapidamente portata ad uno stadio evolutivo adeguato per giocarlo, come si vede anche nel ‘900 con la creazione cosciente di lingue normalizzate comuni in vari stati, come Israele, Indonesia, Macedonia e altri.
In Europa un senso della nazionalità si ha dopo la costituzione dell’impero carolingio, e diventa chiara una differenziazione tra le varie parlate germaniche, il francone, l’alemanno, il bavarese, il longobardo. Carlo Magno sconfigge il re longobardo Desiderio nel 774 e unisce le stirpi gallo-romanze e germaniche dell’Europa continentale in un solo impero. Egli si fa promotore del latino come lingua unificante delle popolazioni soggette: nella Admonitio generalis di Aquisgrana (789) e poi con il Sinodo di Francoforte (794) Carlo Magno invita i vescovi e gli abati ad usare il Pater noster, ma promuove anche lo studio del volgare come mezzo di divulgazione del Vangelo tra le popolazioni. I tedeschi si limitano a tradurre dal latino i testi base del Cristianesimo. Carlo Magno nell’813 associa al potere il figlio Ludovico il Pio, che gli succede alla sua morte (814). Nell’817 Ludovico il Pio associa al governo il proprio primogenito Lotario, che alla morte del padre (840) gli succede nel titolo e nella parte centrale dei possedimenti imperiali. Agli altri due figli di Ludovico il Pio, Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, figli di secondo letto, toccano rispettivamente la parte occidentale e quella orientale. I due muovono guerra a Lotario e giurano reciproca alleanza contro il comune nemico davanti ai rispettivi eserciti, e a loro volta gli eserciti giurano di abbandonare il loro re se questi non rispetta il giuramento. È singolare che Ludovico il Germanico giura in francone, mentre Carlo il Calvo giura “in teudisca lingua”, cioè ognuno giura nella lingua dell’altro, mentre gli eserciti giurano ciascuno nella propria. Tale fatto ci è stato tramandato in un documento interessante, i giuramenti di Strasburgo (Strassburger Eide) riportati dallo storico Nitardo. Abbiamo qui forse il primo significativo esempio del distacco dal latino anche nei documenti ufficiali statali. Con il trattato di Verdun (843) viene sancita la divisione dell’impero in tre parti, e prende corpo una divisione linguistica a livello diplomatico. I Vangeli verranno tradotti in tedesco nell’Evangelienbuch (865) e diffusi nel Liber Evangeliorum theodisce conscriptus di Otfrid von Wiessenburg, primo poeta tedesco di cui si conosce il nome. È un’esposizione poetica con rima finale in francone dei 4 vangeli della Vulgata, nella quale la rima sostituisce per la prima volta completamente l’antica allitterazione.
Se il latino fu a lungo la sola lingua scritta conosciuta anche a livello parlato dai regnanti e uomini di cultura, la sua posizione iniziò a vacillare con i grandi cambiamenti avvenuti nella struttura economica, sociale e politica dell’Europa, resi impetuosi dalla scoperta dell’America e dal diffondersi del commercio, che prese a svolgersi in maniera preponderante al di fuori del Mediterraneo, dove il latino non era più lingua comune. La decadenza del latino come lingua diplomatica a favore del francese è fortemente segnata dalle paci di Vestfalia (1648) firmate a Münster con la Francia e a Osnabrück con la Svezia, che pongono fine alla guerra dei Trent’anni e danno un nuovo assetto all’Europa. La sovranità degli stati imperiali, che possono stringere alleanze autonome purché non contro l’imperatore, è garantita dallo ius foederationis. In quelle trattative il latino è ancora la lingua scritta dei diplomatici, ma non è più correntemente parlata. I trattati di Utrecht (1713) e Rastadt (1714) pongono fine alla guerra di successione spagnola, di fatto la prima guerra di dimensioni mondiali, che si combatte anche sul continente americano; in tali paci, che segnano un affermarsi dell’Inghilterra nella politica europea, che non è più soltanto continentale, vari diplomatici avranno bisogno di interpreti.
Durante tutto il 18° secolo il francese acquisì una posizione di prestigio sempre maggiore. In Russia già Pietro il Grande usava il francese e Caterina II iniziò una vera e propria campagna per francesizzare le classi dominanti del suo impero, convocando in Russia insegnanti, artisti e letterati francesi. Le “persone per bene” si vergognavano di parlare il russo, e i rampolli dell’aristocrazia lo conoscevano a malapena. Anche le istruzioni governative ai propri diplomatici all’estero erano redatte in francese. A tale propaganda si oppose lo scienziato e letterato Mihail Lomonosov, e le sue idee ebbero influenza sulla successiva evoluzione della lingua russa.
L’Inghilterra si oppose alla diffusione del francese fin dall’inizio, sia per il fatto che lo stato britannico si era costituito ben prima di altri stati europei, sia per il fatto che gli Stati Uniti avevano scelto l’inglese come lingua nazionale e nel 19° secolo erano in piena espansione. Questa opposizione al francese causò che in vari trattati internazionali dove il francese aveva sostituito il latino come lingua di stesura fosse aggiunta la clausola che l’uso del francese non pregiudicava in nessun modo il diritto degli stati di avere il trattato redatto nella propria lingua, né costituiva un precedente per la redazione di altri trattati internazionali. Un codicillo simile si trova nel trattato di Aquisgrana (1748) che pose fine alla guerra di successione austriaca, in quello di Parigi (1763), in quello di Versailles (1783) e nell’Atto Finale del Congresso di Vienna (1815). Il francese appare quindi sostituto del latino in via eccezionale, con la consapevolezza che la tradizione restava aderente al latino.
La diversità, nella diplomazia internazionale, tra la posizione del latino universalmente accettato e quella del francese accettato con la clausola che tale uso non costituisse un precedente, si spiega logicamente con la differenza del carattere sociale e politico delle due lingue. Il latino medievale non era una lingua nazionale, ma una lingua di classe, comune ai ceti dominanti dei paesi europei. Usando il latino per i propri contatti internazionali, i diplomatici avevano la sensazione di usare una lingua propria, non una lingua straniera. Anche dopo la formazione dei grandi stati nazionali il latino continuava a presentarsi come una lingua neutrale, che non offendeva nessun sentimento nazionale. Invece il francese, lingua nazionale di uno stato potente, non aveva questa caratteristica di neutralità. Quanto più si andava affermando il concetto di nazione in senso etnico, e il concetto di sovranità nazionale, che andava via via sostituendo la nozione di sovranità del monarca, tanto più diminuiva la possibilità del francese, come di qualsiasi altra lingua nazionale, di occupare la posizione di una lingua comune neutrale nelle relazioni internazionali.
Il francese comunque prendeva piede anche in strati sociali meno elevati, quando la rivoluzione industriale portò alla distribuzione internazionale delle merci. Nell’Ottocento le lingue ufficiali di uno stato erano usate principalmente all’interno dello stato stesso, che già doveva fronteggiare la difficoltà di fornire una lingua unica ai propri cittadini, quasi sempre portatori di una lingua, o dialetto, o parlata locale che solo recentemente assurgerà allo status di “lingua minoritaria”.
Dal punto di vista degli scambi culturali e della comunicazione, le lingue ausiliarie erano (e restano) utili, ma essenzialmente erano limitate a certe zone definite e, anche allora, a strati sociali piuttosto modesti. Quando le relazioni internazionali su vasta scala ancora non esistevano, o cominciavano appena ad evolversi, queste lingue soddisfacevano i bisogni limitati di comunicazione. In Europa la situazione è mutata in maniera essenziale con la scomparsa dell’uso generalizzato del latino e la formazione delle lingue letterarie nazionali, in conseguenza della disgregazione del feudalesimo e del parallelo crearsi di nazioni e di stati nazionali moderni o di federazioni multinazionali. Jorge Luis Vives, nella sua opera De disciplinis scriveva nel 1532:
Sarebbe bello se esistesse una lingua sola, che potesse essere usata da tutti i popoli […] Il latino scomparirà; e allora ci sarà una grande confusione in tutte le scienze, e i popoli vivranno in un isolamento profondo […].
2. Le lingue costruite: dall’idea al progetto
L’idea di una lingua “artificiale” come si diceva allora, quale noi oggi associamo alle lingue meglio dette “pianificate”, come l’Esperanto, l’Ido, il Volapük o l’Interlingua, è andata crescendo nei secoli molto lentamente, dalle antiche prove di “scienza universale”, scrittura segreta, ideografia, scrittura tramite figure, linguaggio dei gesti, magia delle cifre, fino alle idee della mistica dei numeri, la provenienza divina della parola e la potenza dei singoli vocaboli. Una panoramica fin dalle più remote origini della scuola pitagorica o della filosofia vedica sarebbe fuori dei nostri limiti; ci limiteremo perciò a fornire soltanto qualche esempio.
Molti grandi saggi, in ogni tempo e luogo, hanno sognato di ritrovare il paradiso perduto della lingua primitiva perfetta, specchio di Dio. In seguito, col progresso materiale, i filosofi si sono fidati sempre più della razionalità umana, ed è comparsa l’idea di una lingua perfetta da creare da parte degli uomini, o di una lingua primitiva comune da ricostruire da parte dei filologi.
Tra i primi tentativi vi fu quello di ricostituire la “lingua di Adamo” attraverso l’ebraico. Un secolo dopo si pensò di trovare radici comuni nelle famiglie linguistiche indoeuropea, semitica, amerindia. Ma ciò avrebbe richiesto troppo tempo, mentre l’uomo è impaziente. Nascono così cervelli brillanti che hanno una notte l’ispirazione di una lingua perfetta, di una lingua ideale e la costruiscono in qualche settimana. Con il 18° secolo si apre una vera e propria industria di lingue cosiddette “universali”, vi è un’orgia di progettisti ambiziosi, e i loro ideatori si credono dei nuovi Messia. Parallelamente nell’ambiente scientifico va avanti uno studio serio sui gesti dei selvaggi, sul linguaggio dei gesti dei sordomuti, sui geroglifici e sull’ideografia cinese; si creano alfabeti universali, progredisce la logica e l’analisi matematica; nasce un sistema di segnalazione dei marinai, una simbologia dei chimici, una classificazione per gli astronomi; si evolve una lingua latina scientifica ausiliaria per i biologi, e così si prepara una base seria sulla quale le fantasie precedenti possano realizzarsi in forma utile. Il problema della lingua universale si sdoppia, e si divide in due correnti: da una parte una lingua pratica per scrivere e parlare, dall’altra una pasigrafia ideologica e teorica, eminentemente scritta e spesso costituita da un codice numerico. Secondo la classificazione di Couturat e Leau due pasigrafie sono usate realmente, il codice Morse e la classificazione libraria del Dewey.
Tra questi due estremi ci sono centinaia di prove ibride intermedie. La distinzione tra lingue “naturali” e lingue “artificiali” è soltanto un retaggio della scolastica medievale e di un falso razionalismo. La filologia ha scoperto quanto artificiali siano tutte le lingue etniche letterarie e quanto naturale diventi qualsiasi lingua ausiliaria parlata che sia costruita coscientemente. E tuttavia, nonostante il progredire degli studi filologici avesse da gran tempo dimostrato come ogni lingua sia frutto di una più o meno cosciente pianificazione, e l’illusione che “le lingue nascono dal popolo” fosse, quella sì, una posizione romantica sorpassata, ancora molti intellettuali guardano all’esperanto, che è la lingua pianificata di maggior successo, con sospetto per via della sua nascita a tavolino, come se lo sviluppo di più generazioni con un totale, nell’arco dei decenni, di alcuni milioni di parlanti non fosse sufficiente a riscattare la lingua da questo suo peccato originale. Spesso i manuali di esperanto hanno una prefazione che respinge certi pregiudizi; resterà famoso il manuale di Bruno Migliorini, pubblicato da Paolet nel 1923, in uso ancora adesso, rimodernato in numerose edizioni successive (l’ultima ha una prefazione di De Mauro). Nell’introduzione di questo manuale, che più che un’introduzione è un vero saggio di linguistica, Migliorini confuta, con argomenti che da allora nulla hanno perso in attualità, le usuali affermazioni sulla cosiddetta “artificialità” dell’esperanto affermando: “le lingue artificiali meglio costruite sono soltanto un po’ più artificiali delle nostre lingue culturali”.
Non sarebbe affatto assurdo vedere nello sconosciuto ideatore dell’alfabeto fonetico il primitivo capostipite di tutti i successivi creatori di lingue universali. Giungiamo così a capire i vari progetti di lingue e alfabeti universali che si sono susseguiti senza interruzione dai primi segni di espressione dell’uomo primitivo fino alle più elaborate ed espressive lingue pianificate odierne.
Una lista storica di lingue internazionali si trova in P. E. Stojan, Bibliografio de internacia lingvo (Bibliografia della lingua internazionale); Stojan era un russo della prima metà del secolo scorso, e la sua opera può dirsi completa fino all’anno di pubblicazione (1929). Sono registrate, in ordine cronologico, 653 lingue (o progetti) a partire dal 12° secolo, delle quali ben 80 solo nel ventennio 1870-1890, e di molte di esse vi è una descrizione. Un’ottima enciclopedia in italiano riguardante le lingue costruite a tavolino è quella di Albani e Buonarroti, che comprende 2900 voci, uno schema analitico delle lingue immaginarie e un prospetto cronologico dei principali ideatori. Di quest’opera è curioso il fatto che nessuno dei due autori sia un linguista di professione: il primo è un esperto di economia, l’altro è un grafico. Sull’interlinguistica e l’esperantologia è uscito recentemente in Germania un corposo volume di Detlev Blanke, che ha una bibliografia di circa 800 titoli, la più completa al momento.
Per una storia della lingua universale ci sono parecchie opere; oltre a quelle citate di Eco e di Couturat e Leau ne citiamo una, di Ernst Drezen, che ha valore storico perché notevole per il tempo in cui fu scritta; l’altra, di Aleksandr Duliĉenko, è divulgativa ed è apparsa in Estonia in russo nel 2003, con recentissima traduzione in esperanto10.
Come primo esempio di tentativo di lingua universale citiamo la lingua pansofica di Comenius. Essa era ispirata ad una pansofia, cioè ad una sapienza universale, di cui Comenius scrive in vari libri, in particolare nella Pansophiae Diatyposis (Danzica, 1643). L’ideale pansofico è la ricerca di un metodo e di un linguaggio che consenta di acquisire tutto lo scibile. Ciò viene ostacolato dalla moltitudine e dalla diversità delle lingue, che si può superare tramite una lingua comune (monoglottia):
Una lingua che sia dieci volte più facile di quella latina, in quanto del tutto libera da anomalie, cento volte più perfetta in quanto pronta ad esprimere tutte le cose e tutti i concetti in ogni loro carattere distintivo, mille volte più adatta ad esprimere armoniosamente le qualità delle cose, poiché pone, al posto di definizioni, singoli nomi in perfetta corrispondenza dei numeri, delle misure e dei pesi delle cose stesse.”
Un altro scienziato che si è dedicato al problema è Wilhelm Gottfried Leibniz. Matematico, diplomatico, storico, egli ha armonizzato antiche idee con progetti nuovi al fine di creare una lingua universale. Tutti gli ideatori di lingue universali del 18° e del 19° secolo sono stati sotto l’influsso di Leibniz, che a sua volta aveva studiato ed ereditato idee da Bacone, Cardano, Kircher, Raimondo Lullo e altri. Da idee piuttosto diverse, come crittografia, ideografia, geroglifici, Leibniz concepì l’ispirazione di una lingua universale, o piuttosto di un complesso universale di segni che possa esprimere il pensiero umano, espresso così nebulosamente con le parole. “Dio creò la lingua” era la credenza degli indiani antichi; “Adamo creò la lingua” credevano i saggi dell’Europa medievale. In entrambe le filosofie la lingua si presentava come un prodotto artificiale, in principio perfetto e unico, e in seguito degenerato, frantumato, rotto. Leibniz era un vero cosmopolita: slavo di origine, tedesco-orientale di nascita, viaggiò molto, scrisse principalmente in francese e in latino, progettò una unione di cattolici e protestanti, studiò e incoraggiò a studiare lingue dell’Asia allora sconosciute, ebbe corrispondenza col re di Francia e con lo zar di Russia, e progettò di fondare una società mondiale di missionari. Era uno scienziato universale, enciclopedico, e fu fondatore di una filosofia dell’armonia, secondo la quale “l’universo è regolato da un ordine perfetto” e “l’anima e il corpo si incontrano data l’armonia che c’è in tutte le sostanze, perché tutte sono rappresentazioni del medesimo universo”. Già da adolescente aveva sognato una lingua universale: la sua Ars combinatoria (1666) fu scritta quando Leibniz non aveva ancora 19 anni. Non tutte le sua opere hanno già visto la luce: nella biblioteca di Hannover esistono ancora manoscritti non pubblicati, in francese, in latino, in tedesco.
Per quanto finora è stato pubblicato, due sono stati i suoi progetti sull’argomento: uno è un sistema di calcolo logico sotto il nome Characteristica universalis; il secondo è una vera lingua internazionale pratica su base latina con una grammatica semplice e regolare, nella quale Leibniz descrive dettagliatamente la derivazione dei verbi dai sostantivi. In un altro manoscritto Leibniz dice che in questa lingua universale verranno scritti poemi e inni da potersi cantare.
Altrove Leibniz sogna un “Ordo caritatis. Societas Pacidianorum” che raccoglierà tutto il sapere dell’uomo, elaborerà una lingua opportuna e organizzerà missioni tra i popoli selvaggi per diffondere tra questi l’idea della cultura. È dunque proposta una vera operazione culturale mondiale. E scrive ancora:
Questa lingua sarà il maggiore strumento della ragione. Oso dire che questa sarà l’ultima fatica dello spirito umano, e quando il progetto sarà realizzato, dipenderà solo dagli uomini la loro felicità, perché avranno uno strumento che servirà per entusiasmare la ragione non meno di quanto il telescopio serva per rendere più acuta la vista. Sono certo che nessuna invenzione sarà importante quanto questa, e nulla potrà rendere del pari famoso il nome del suo ideatore. Ma ho motivi ancora più forti per pensare ciò, perché la religione, che seguo fedelmente, mi assicura che l’amore di Dio consiste nell’ardente desiderio di raggiungere il bene comune e il mio intelletto mi dice che nulla contribuisce maggiormente al bene di tutti gli uomini quanto ciò che lo perfeziona.
Connessi ad una lingua universale basata sulla logica sono tutte le classificazioni che usano simboli, come la matematica, la chimica, l’astronomia, la medicina, la farmacia. La classificazione libraria del Dewey presenta tramite cifre un vero vocabolario: 53 = fisica; 535 = ottica; 4917 = lingua russa; 4924: antico ebraico ecc. Manca solo un meccanismo grammaticale per trasformare la classificazione decimale in una vera lingua. Il russo Češihin nel 1924 aveva proposto di trasformare tale pasigrafia in una pasilalia, sostituendo alle cifre delle sillabe prese dai nomi delle note musicali (la grammatica sarebbe stata simile a quella dell’esperanto). La proposta compare nel 1927 sulla rivista «Schola et vita» che si pubblicava a Milano e che, nata nel 1926, dal 1928 al 1938, anno della cessazione delle pubblicazioni, fu l’organo della Academia pro Interlingua, fondata da Peano.
Un tentativo estremamente ingegnoso fu il Solrésol, progetto di lingua universale basato sui sette segni musicali ed elaborato da Jean-François Sudre. Una prima idea nata nel 1817 fu elaborata e poi, nel 1827, proposta all’Accademia francese delle Scienze; un testo completo vide però la luce soltanto nel 1866, dopo la morte dell’ideatore. I segni musicali, veramente universali, almeno nella musica del mondo occidentale dell’epoca, offrono varie possibilità di espressione: la lettura vocale dei segni stessi, la loro cantabilità, la scrittura su un pentagramma, la trascrizione in cifre arabe, la presentazione tattile toccandosi con l’indice della mano destra le falangi della sinistra. Il contrario di un’idea si indica invertendo i segni: mi-sol = il bene, sol-mi = il male; Do-mi-sol = Dio, sol-mi-do = Satana. I gradi di un aggettivo sono indicati con un aumento del sonoro, il femminile con la ripetizione (e quindi, foneticamente, con l’allungamento) della vocale finale. Il progetto incontrò anche consensi tra persone importanti, come Napoleone III, Victor Hugo, Humboldt, Lamartine. Sudre si dedicò anche alla telefonia, scrivendo un codice per la trasmissione a distanza di segnali fonici.
Una proposta del tutto teorica è quella di Giusto Bellavitis, un professore di matematica dell’università di Padova. In una comunicazione all’Istituto Veneto del 1862 egli presenta una lunga lista di caratteristiche che una lingua universale dovrebbe avere: un lessico internazionale, un sistema semplice di derivazione di parole da un numero limitato di radici, una larga varietà di costruzione, un sistema di desinenze per gli aggettivi che ne determinino il grado, una grande diversificazione delle voci verbali per esprimere tempi, modi, intenzioni: indicativo, condizionale, potenziale, dubitativo, interrogativo. E ancora, il Bellavitis suggerisce un sistema di composizione delle parole da radici diverse, e propone un adattamento a numeri e a segni. Tuttavia nulla di concreto, non la scelta di una radice, non un esempio di applicazione. Discorsi teorici che non trattano minimamente della fatica necessaria per imparare una serie di corrispondenze astruse tra le parole a cui l’uomo è abituato e le parole, o i segni, della nuova lingua. La conclusione è un lungo elenco di cose che i costruttori di tale lingua filosofica dovrebbero fare, senza nessun suggerimento pratico.
L’ideologia retrostante a questi tentativi era dunque di creare un linguaggio universale basandosi su strutture universali, come i segni musicali, o la numerazione, o un adattamento del latino. Esse sono perfettamente neutrali, non privilegiano un popolo rispetto ad un altro, sono la soluzione democratica (se si può usare questo termine in un mondo in cui un’alta percentuale delle persone era analfabeta) del problema della lingua per i contatti internazionali. Si tratta di lingue principalmente “a priori”, e come tali non hanno un aggancio sicuro nella mente umana: la logica aiuta la costruzione delle parole e fa giustizia delle irregolarità delle lingue etniche, ma se non c’è una facile acquisizione delle radici lessicali la lingua risulta impraticabile. È con l’affermarsi delle lingue nazionali che gli studiosi interessati al problema si indirizzano quindi verso le lingue “a posteriori”, cioè basate su lingue già esistenti, che forniscono, in maniera diversa, strutture grammaticali già collaudate, un lessico che recupera forme originarie comuni a vari ceppi linguistici, una disponibilità all’uso che le lingue a priori non fornivano. La seconda metà dell’Ottocento offre numerosi progetti, tutti basati sulle principali lingue occidentali, con un attento dosaggio di prelievi lessicali o grammaticali dalle lingue dei vari ceppi, ma quasi esclusivamente lingue neolatine o germaniche. Si può notare come questa esplosione di idee interessi principalmente l’Europa centro-occidentale, diciamo a occidente della Vistola: l’Accademia di Pietroburgo non è più alla pari dell’Accademia di Berlino o dell’Accademia di Francia, quando i migliori scienziati potevano passare dall’una all’altra insegnando indifferentemente in latino a studenti di tante nazioni diverse.
Potrebbe perciò apparire sorprendente che l’idea della lingua internazionale che finora ha riscosso maggior successo e si è dimostrata vitale e longeva, cioè l’esperanto, sia nata in Polonia, allora una provincia dell’impero russo. Vedremo che la motivazione è un misto di internazionalismo pacifista e di un nazionalismo specifico.
3. L’Esperanto e il suo ambiente
La prima grammatica della Lingua Internazionale oggi conosciuta sotto il nome di “esperanto” esce a Varsavia il 26 luglio 1887, presso la stamperia Kelter. È in lingua russa e la copertina riporta il titolo МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯЗЫКБ e lo pseudonimo dell’autore Дръ ЗСПЕРАНТО16. Già sulla copertina stessa si leggono le prime parole nella nuova lingua “por Rus,o,j” (per i russi), e nello stesso anno seguono le versioni in polacco, tedesco e francese20. La copertina indica anche Prefazione e manuale completo e riporta il motto “Perché una lingua sia mondiale non basta darle un tale nome”.
Sotto lo pseudonimo di Dr. Esperanto (che nella nuova Lingua Internazionale significa “il dottore che spera”) si cela l’oculista Lazzaro Zamenhof, un ebreo polacco nato nel 1859 a Bjałystok, governatorato di Grodno, regione della Polonia allora sotto l’impero russo. Suo padre, Mordechai cristianizzato in Markus, era un professore di lingue, autore di testi scolastici di larga diffusione, studioso dei testi biblici, una delle poche persone appartenenti alla ristretta intelligencija ebraica di cui il regime zarista si fidava, tanto da assumerlo anche nell’ufficio censura della stampa. Le lingue della famiglia Zamenhof erano il russo usato dal padre e l’yiddish usato dalla madre; la comunità ebraica circostante parlava l’yiddish, mentre la lingua dell’istruzione scolastica, dei militari di stanza e della burocrazia era il russo; la borghesia parlava polacco, contadini e commercianti parlavano tedesco, ed era presente una minoranza lituana. Il giovane Lazzaro, cresciuto in un ambiente multilingue, parlava correntemente russo, yiddish, polacco e tedesco, aveva grande padronanza del francese studiato fin da piccolo, leggeva correntemente il latino e l’ebraico della Bibbia; del greco e dell’inglese aveva una conoscenza grammaticale, mentre del lituano probabilmente non conosceva più di qualche frase per una conversazione elementare. Come lingua propria egli considererà sempre il russo, lingua nella quale da giovane compone anche un dramma in cinque atti e nella quale sogna di distinguersi come poeta; ma avrà sempre difficoltà a definirsi dal punto di vista dell’etnia, tanto che in un’occasione dirà di considerarsi semplicemente “figlio della terra polacca”. Una sua lunga lettera in russo a Nikolaj Borovko del 1895, la cui traduzione in esperanto fu pubblicata nel 1896, racconta di come fosse nata in lui l’idea di una lingua internazionale27. Cresciuto in una regione dove convivevano, tra forti contrasti, etnie estranee tra loro anche perché parlanti lingue diverse, fin da bambino aveva avuto l’idea che da grande avrebbe eliminato questa sciagura. Dopo aver riconosciuto come utopie e quindi rifiutato tanti sogni infantili, da uno di questi tuttavia non riesce a staccarsi: la possibilità di una lingua comune a tutti gli uomini. Quando al liceo studia il latino e il greco e conosce la semplicità della grammatica inglese si rende conto che non è percorribile un recupero delle lingue classiche e che è necessaria e possibile una lingua nuova, artificiale, facile, tramite la quale tutti si possano intendere su un piede di parità28. Un primo progetto ha già corpo nel 1878, quando il giovane è all’ultimo anno del liceo29; sperimentazioni e conseguenti forti modifiche successive porteranno poi, nel 1887, alla pubblicazione della grammatica citata.
Questo libro è costituito da una prefazione, tre saggi che illustrano il problema della lingua internazionale e la soluzione che l’autore propone, un modulo in cui il lettore può dichiarare la propria intenzione di studiare la lingua se almeno altri dieci milioni di persone fanno la stessa promessa; inoltre c’è una grammatica essenziale di 16 regole, un vocabolario di 917 radici e alcuni brani letterari nella nuova lingua. Il tutto occupa 40 pagine.
Nella prefazione Zamenhof presenta i tre problemi principali per il lancio di una lingua internazionale: questa deve essere facile, coloro che l’hanno studiata devono potersi intendere subito senza aspettare che essa sia generalmente accettata, e inoltre bisogna vincere l’indifferenza del mondo. Lo Zamenhof sa benissimo delle numerose prove precedenti e del loro fallimento e si chiede perché uscire con una nuova lingua; che cosa avrebbe questa di diverso tanto da sperare per essa un diverso destino? Le lingue precedenti, egli dice, hanno parzialmente risolto, se pure, uno solo di questi problemi.
3.1 Il Volapük
L’esperanto esce in un momento in cui è al suo apice il Volapük, altra lingua internazionale, iniziata dal sacerdote cattolico tedesco Johann Martin Schleyer30 (1831-1912). Questi fu parroco in varie località; poliglotta, scrisse poesie e drammi in tedesco, latino e Volapük; fu editore e redattore di riviste. Nella primavera del 1875 Schleyer era andato a Roma ed era stato ricevuto in udienza da Pio IX, che benedisse il suo progetto di pubblicare «Sionsharfe» (L’arpa di Sion), un foglio mensile di poesia cattolica. Al suo ritorno, dietro denuncia e istigazione di vecchi cattolici conservatori, fu arrestato e incarcerato per quattro mesi nella fortezza di Rastatt per una sua predica con accenti favorevoli al socialismo; liberato, abbandonò la sua parrocchia di Krumbach e nel dicembre 1875 si stabilì come parroco a Litzelstetten, un paesino di trecento anime sulla riva tedesca del Lago di Costanza. Qui iniziò una intensa attività pastorale, a cui affiancò una altrettanto intensa attività pubblicistica. Acerrimo nemico del liberalesimo, fu infine pensionato come parroco per malattia su sua richiesta, e si trasferì a Costanza. Nel 1894 fu nominato cubicularius secretus da Leone XIII, dietro raccomandazione dell’arcivescovo Johann Christian Roos (1826-1896), che nella lettera di presentazione espone questi motivi:
[…] già nel 1867 ha scritto una poesia sugli eroi della battaglia di Mentana31, e poi delle poesie in latino in lode del Sommo Pontefice. Anche se queste sono ben a ragione lodate, egli ha ricevuto da luoghi vicini e lontani la più grande lode per il fatto che ha […] inventato una nuova lingua universale […]. Non ho il diritto di giudicare il valore oggettivo di questa lingua, ma credo fermamente che un prete cattolico come inventore di questa lingua contribuisca alla gloria della Chiesa, tanto più che personalmente egli vive una vita esemplare, pia e povera, accontentandosi di una pensione modesta.
Abbiamo qui una riprova del fatto che la lingua universale, non soltanto da parte del suo autore, ma da parte della Chiesa, viene vista come un’ “opera buona”.
Il Volapük era stato pensato come primo embrione nel 1878: in quell’anno Schleyer depositò all’Archivio delle Poste di Berlino un alfabeto internazionale che doveva essere di aiuto per l’inoltro della corrispondenza che rischiava di smarrirsi per difficoltà ortografiche nell’indirizzo. Pochi mesi dopo viene presentata già una lingua fatta: i suoi primi elementi compaiono nel numero di maggio 1879 della rivista «Sionsharfe». La grammatica è molto regolare, ma non semplice e risente dell’influsso del tedesco: i sostantivi e i pronomi personali sono declinati con quattro casi, formati con desinenze (-a per il genitivo, -e per il dativo, -i per l’accusativo), alle quali si aggiunge la desinenza -s per il plurale, gli aggettivi sono invariabili e terminano in -ik; ma il lessico, che deriva prevalentemente da radici inglesi e latine (spesso nei loro exitus nelle lingue romanze), è reso irriconoscibile, fatto dovuto a certi principi teorici: ad esempio, nell’alfabeto manca la lettera r, in quanto di difficile pronuncia per alcuni popoli orientali, per cui le parole appaiono strane anche alle persone colte che conoscono le maggiori lingue europee. Il nome Volapük è un termine composto da vola, genitivo di vol (< world), e pük (< speak), cioè “lingua del mondo”. Il Padre nostro in Volapük inizia così:
O Fat obas, kel binol in süls, paisaludomöz nem ola! Kömomöd monargän ola!
Con molta fatica si possono riconoscere Fat (< Father), binol (< bin + ol, pronome di seconda persona), süls (< coelis, plurale), nem (< name), monargän (< monarch + land) e nei verbi le radici salud e köm (< kommen); ola è il genitivo del pronome di seconda persona singolare ol e quindi funziona da aggettivo possessivo, “tuo”. I pronomi personali iniziano tutti per o- a cui segue una consonante, che però non ricorda nessun pronome delle lingue europee: obas è il plurale del genitivo del pronome di prima persona ob, quindi “nostro”. Estremamente ricca, ma si potrebbe dire eccessivamente, è la coniugazione dei verbi, tutti regolari: sono esprimibili tramite morfemi, oltre che i tempi, i modi e la forma attiva e passiva, anche l’aspetto, la persona, il numero; esistono otto modi, tra i quali l’ottativo e lo iussivo.
Nel 1880 lo Schleyer pubblica a Sigmaringen Volapük, die Weltsprache. Entwurf einer Universalsprache für alle Gebildeten die ganzen Erde. La lingua è perciò dichiaratamente diretta alle persone “istruite”, e l’iniziatore ne è ben cosciente. Questa restrizione elitaria non ne frena la diffusione: in breve tempo il Volapük raggiunge il milione di aderenti, si tengono corsi molto frequentati, si formano gruppi di adepti in quasi tutte le città importanti europee e americane. In Italia viene insegnato facoltativamente in alcune scuole col permesso del Ministero, tuttavia soltanto nel 1890 esce un corposo vocabolario italiano-volapük e volapük-italiano.
Si tengono tre congressi, nel 1884, nel 1887 e nel 1889, ma la lingua non regge alla prova della conversazione; nel primo congresso si parla essenzialmente tedesco, nei successivi meno, ma la comprensione diretta tra partecipanti è tutt’altro che soddisfacente. Il declino del Volapük è molto rapido, come rapida era stata la sua ascesa: non viene meno l’idea che possa funzionare una lingua pianificata, ma gli adepti vanno alla ricerca di qualcosa di più facile, dove ciascuno possa trovare qualche elemento riconoscibile della sua lingua etnica. Il motivo del crollo del Volapük è probabilmente tutto qui: l’estrema deformazione delle radici toglieva la possibilità agli utenti di sentirlo una lingua propria, di sentire in essa qualcosa di sé stessi. Tutti i sostantivi erano maschili, e il femminile si formava con un prefisso, che si perdeva nel parlato, dato che l’accento cadeva sempre sull’ultima sillaba; inoltre la fonetica presentava suoni sia vocalici che di gruppi consonantici che non avevano riscontro nelle lingue europee.
Zamenhof stesso quasi si scusa di aver proposto un’altra lingua quando esiste, e appare in auge, il Volapük. In una lettera in esperanto a Schleyer del 27 novembre 1887, che accompagna l’omaggio del primo manuale di esperanto nella versione tedesca, egli scrive (le sottolineature sono nell’originale):
[…] Le mando il frutto del mio lungo lavoro; sia questo un segno della mia profonda stima per il nobile idealista che ha lavorato per l’umanità, senza temere le risate della gente. Io comprendo benissimo quanto Lei ha dovuto sopportare, perché io stesso ho seguito la medesima strada. Quando il mio lavoro era già pronto ho dovuto aspettare quattro anni e sono stato il bersaglio di un dileggio ininterrotto – fin quando ho avuto la possibilità di pubblicare la mia opera.
Quando cinque anni fa ho sentito parlare del Volapük non ho buttato via il mio lavoro, perché la costruzione del Volapük mi sembra non del tutto pratica; ho detto a me stesso che una lingua mondiale deve essere prima di tutto comprensibile, e tutto il vasto materiale che già di per sé è diventato internazionale deve rimanere intatto.
[…]
Io apprezzo il Suo nobile desiderio di essere utile all’umanità; con la massima stima per l’autore del Volapük io lavoro non contro il Volapük, ma per l’idea. Sacra è per me l’idea di una lingua per tutto il mondo, e in qualsiasi modo l’umanità ce l’avrà io sarò contento e felice. Se mi si mostrerà che il mio lavoro è dannoso per l’idea, lo distruggerò io stesso, nonostante vi abbia dedicato la parte migliore della mia vita; se il giudizio del mondo non sarà decisivo, la “Lingua internazionale” resterà insieme al Volapük, come due amici, che hanno uno scopo nella vita. O una delle lingue morirà da sé, o l’umanità avrà due lingue, e anche questo sarà per il mondo molto meglio che non restare senza una lingua mondiale.
Mi scusi se Le ho scritto nella mia lingua, lo faccio non per scortesia, ma per darLe la prova della mia lingua.
Con la massima stima
Esperanto
Interessante è l’affermazione di Zamenhof di aver conosciuto il Volapük cinque anni prima della lettera, cioè nel 1882, quando l’esperanto era già arrivato per lo meno al suo terzo stadio. Le modifiche che Zamenhof apportò al suo progetto fino all’uscita pubblica del 1887 tuttavia non sembrano aver risentito dell’influenza del Volapük. Successivamente, in una non terminata serie di lunghi articoli sulla rivista «La Esperantisto» (L’esperantista) degli anni 1889 e 1890 Zamenhof analizzerà in maniera molto critica il Volapük dal punto di vista linguistico, lamentando anche il danno che il prevedibile collasso del Volapük apporterà all’idea di una lingua internazionale. Resterà comunque in Zamenhof una grande stima per Schleyer e per il suo lavoro pionieristico, affermata in più di un’occasione anche parecchi anni dopo.
La lettera comunque pone l’accento sulla componente ideale: lavorare per una lingua mondiale è un impegno sacro, indipendentemente dal successo del proprio lavoro. Ritroviamo qui una sintonia con le motivazioni che l’arcivescovo Roos porterà nel caldeggiare l’onorificenza pontificia per l’abate Schleyer.
3.2 Zamenhof attivista politico
L’altra componente per convincere il mondo che una lingua pianificata può funzionare è quella letteraria. Zamenhof è cosciente che la letteratura è l’anima di una lingua e che per dare credito ad un progetto di lingua internazionale nato a tavolino è necessario convincere i lettori dell’opuscolo che in tale lingua si possono esprimere tutte le sfumature proprie delle letterature di tutti i popoli. I brani che compaiono sono, se tralasciamo una lettera di convenevoli che serve da modello, due poesie originali, Mia penso (Il mio pensiero) e Ho mia kor’ (O mio cuore), la traduzione del Padre nostro, la traduzione dei primi dieci versetti della Genesi e la traduzione da Heine En sonĝo princinon mi vidis (Mir träumte von einem Königskind).
Perché Zamenhof ha scelto proprio questi brani? Le poesie originali parlano della sua emozione nell’uscire in pubblico con una lingua internazionale avendo sacrificato tutta la giovinezza allo studio per perseguire quell’ideale. La poesia Mia penso era già presente anche nelle precedenti versioni della lingua fin dal 1881, a riprova di quanto Zamenhof sentisse il problema di essere rifiutato dal mondo, di essere deriso. Egli sente perfettamente che la proposta di una nuova lingua internazionale lo colloca tra gli utopisti, fama che mal si accorda con la necessità di apparire serio e affidabile per acquisire pazienti al suo ambulatorio di oculistica.
I versi presentano già licenze poetiche con i sostantivi a finale tronca, le rime sono semplici, ma si intravedono chiaramente le potenzialità letterarie della lingua. Pur avendo le parole in esperanto l’accento sempre regolarmente sulla penultima vocale, e quindi offrendo naturalmente un ritmo di trochei e amfibrachi con le parole generalmente bisillabe e trisillabe, una di queste poesie presenta, con una sagace alternanza di monosillabi e di parole troncate, un incalzante ritmo giambico. Con le traduzioni lo Zamenhof vuole suggerire subito un senso di universalità, e quindi coglie i testi più cari alla religione cristiana e a quella ebraica, che coprono la quasi totalità del mondo che a quell’epoca veniva considerato “civile”. Riguardo alla traduzione da Heine, Zamenhof evidentemente ritiene che una traduzione dal tedesco collochi la nuova lingua in un ambiente più eurocentrico che non una traduzione dal russo, idioma con il quale egli sarebbe ben più intimo. Inoltre Heine era ebreo, era popolare anche in Francia, avendo sposato una francese ed essendosi trasferito a Parigi. La poesia in questione, contrassegnata dal numero “XLI” nella raccolta Lyrisches Intermezzo apparsa nel 1823, non è tra le più famose del poeta tedesco: parla di un amore impossibile vissuto in un sogno romantico. Vogliamo vedere anche qui un’allusione al sogno di una lingua universale?
È presente anche un’impronta incancellabile del misticismo ebraico e della fede incrollabile nel compito messianico del popolo di Abramo, di Isacco e di Giacobbe. Vivendo fin dall’infanzia in un ambiente di etnie miste, e appartenendo ad una razza che, per esprimere il proprio animo, aveva allora soltanto la scelta tra una lingua morta da secoli e una lingua non propria, bensì degli oppressori, l’idealista Zamenhof inseguiva un sogno illuministico: l’unione di tutti gli uomini in una situazione di uguaglianza e fratellanza, tutti con gli stessi diritti. Gli ebrei, dispersi dalla diaspora in paesi lontani, non avevano una lingua comune46 e quindi non potevano neanche godere del diritto di comunicare tra loro, come facevano gli altri popoli stanziati in un unico territorio. Il sogno di mettere in comunicazione questo popolo disperso si accoppiò subito al sogno di una lingua universale, non nazionale e neutrale, che avrebbe restituito agli ebrei l’indipendenza e a tutti una facilitazione nel comunicare.
La minoranza ebraica era in quegli anni in forte agitazione. In Polonia e Russia esistevano comunità ebraiche che da secoli erano parte molto attiva nello sviluppo commerciale delle loro regioni, ma agli ebrei era vietata una partecipazione attiva alla vita agricola e anche la possibilità di istruzione era molto limitata. Nel 1863 scoppia un’insurrezione nazionale dei polacchi e dei lituani contro l’impero russo; la rivolta fallisce, la repressione dura alcuni anni e lo zar accentua il processo di russificazione delle terre della Vistola; di conseguenza gli ebrei colti abbandonano facilmente il tedesco per il russo, illudendosi che sarebbe presto cambiata la politica antisemita. La famiglia Zamenhof viveva in questo clima collaborazionista e, come abbiamo visto, era una delle poche alle quali l’istruzione era stata consentita fino ai più alti livelli. L’antisemitismo razzista aveva trovato espressione teorica nel saggio del conte Joseph Arthur de Gobineau Essai sur l’inégalité des races humaines che sosteneva la superiorità della razza ariana e spiegava la storia mondiale in termini di vittoria di una razza sull’altra. Il giovane Zamenhof sente attorno alla sua gente un’aperta ostilità, che nel biennio 1881-1882 si concretizza in violenti pogrom; la comunità ebraica è atterrita, e la sua intelligencija diventa consapevole della gravità del problema e comincia a rivendicare una patria per gli Ebrei oppressi. Zamenhof è appena tornato da un biennio di studi presso l’università di Mosca e prosegue gli studi a Varsavia. A Mosca non aveva cessato di interessarsi di lingue, ed aveva elaborato una grammatica di yiddish per ebrei russi, la prima nel suo genere. Lo scopo era di ricostruire una lingua unificante per l’intero popolo ebraico della diaspora. È tra i fondatori di una sezione del movimento Ĥibat Zion (Amore per Sion) e lavorerà per alcuni anni in questo primo movimento di rinascita della nazione ebraica. Questo nazionalismo era antitetico alla teoria degli “assimilisti”, che sostenevano che gli Ebrei non erano né un popolo né una nazione, ma soltanto una comunità religiosa.
A seguito dell’assassinio dello zar Alessandro II nel marzo 1881, effettuato da sicari affiliati alla società Narodnaja Volija (Libertà del popolo), il popolo, con la connivenza del nuovo zar Alessandro III e della polizia, fu istigato contro gli ebrei che furono quindi oggetto di aggressioni, ferimenti, uccisioni, rapine. Per oltre un anno quasi ogni giorno ci furono fatti di sangue in tutto l’impero russo e il giorno di Natale del 1881, a Varsavia, ci fu un’aggressione agli ebrei che poi degenerò in uccisioni e ferimenti. Nella comunità ebraica polacca si pose dunque con urgenza il problema della difesa. Tra le proposte vi fu quella di riunire le varie componenti della diaspora e ricostituire un popolo che avesse la stessa lingua e che emigrasse in una terra dove potesse vivere in pace. La Palestina appariva la scelta più ovvia, ma questo territorio era abitato da arabi e da cristiani ed era da tempo sotto i turchi. Un’altra ipotesi, a cui inizialmente era favorevole anche lo Zamenhof, era l’emigrazione negli Stati Uniti. Si formarono quindi, all’interno delle varie comunità ebraiche, due movimenti: Am-Olam (Popolo eterno), che sosteneva l’emigrazione in America, e Ĥibat Zion che sosteneva la colonizzazione della Palestina. La gran parte degli adepti di Am-Olam emigrò realmente negli USA e molti, insediatisi nelle grandi città, trovarono occupazione nella grande industria e nel commercio; però le poche colonie agricole fondate in Louisiana e in South Dakota non decollarono e sparirono in breve tempo. Invece alcuni adepti di Ĥibat Zion emigrarono in Palestina e fondarono colonie agricole che riuscirono a sostenersi con successo. Aumentarono quindi i sostenitori della soluzione palestinese, ai quali si aggiunse, con ottimismo e piena convinzione, anche Zamenhof, che sostenne questa tesi con articoli in yiddish e in russo sui giornali locali. A Varsavia i membri di Ĥibat Zion erano principalmente gli abitanti del settore lituano della comunità ebraica, tra i quali Zamenhof si sentiva a suo agio. La società doveva acquisire sostenitori e ogni settimana i membri si riunivano, facevano il punto della situazione, pianificavano l’attività della settimana successiva e raccoglievano somme destinate a sostenere gli emigrati in Palestina. La raccolta di somme era illegale, ma Zamenhof riuscì ad evitare fastidi con la polizia spedendo singolarmente il denaro di ogni singola quota, dato che non vi era limite all’esportazione di somme da parte dei singoli cittadini. Egli si adoperò anche perché le varie associazioni ebraiche collaborassero in un’unità di intenti, ora che era stata definita la strategia; alcuni movimenti effettivamente confluirono nella Chowewe Zion (Simpatizzanti di Sion), che mirava ad una colonizzazione della Palestina. Nel 1884 lo zar pubblica il “Regolamento provvisorio” che costringe gli ebrei a lasciare i villaggi e a concentrarsi nelle città: il problema di trovare un territorio in cui poter emigrare diventa acuto.
A fianco di questa intensa attività politica Zamenhof continua ad elaborare segretamente la sua lingua, provando e riprovando, traducendo, scrivendo; si avvicina al Volapük, che trova inadeguato. Negli anni 1881-1882 prende forma un nuovo progetto, che riprende, modificandolo fortemente, il “pra-esperanto” del 1878. Nelle biografie di Zamenhof si legge che il materiale della nuova lingua era in tre quaderni; ci restano una dozzina di testi in poesia e in prosa, dai quali gli esperantologi, in particolare Gaston Waringhien e Itô Kanzi, hanno tentato di ricostruire una grammatica e di comprendere le ragioni delle varie modifiche successive, in particolare nel lessico. Ma il progetto definitivo non è ancora pronto, Zamenhof apporta ancora modifiche notevoli; è molto assorbito dal suo lavoro sulla nuova lingua, ma comunque completa coscienziosamente gli studi, si laurea in medicina a Varsavia nel gennaio 1885 e si specializza in oftalmologia prima presso l’ospedale di Varsavia e quindi, per alcuni mesi del 1886, presso l’università di Vienna.
Nelle famiglie sioniste egli trova compagnia ed amici; presso i coniugi Levite conosce una loro parente di Kovno, Klara Zilbernik, anche lei di una famiglia fortemente sionista. Il fidanzamento avviene nel marzo 1887; contemporaneamente Zamenhof considera la sua lingua internazionale pronta per uscire in pubblico. Alla fidanzata svela il proprio progetto e il futuro suocero finanzia, con la dote della figlia, la stampa della prima grammatica e la sua diffusione, con invii a librerie, accademie, redazioni di riviste e a numerosi intellettuali. Il matrimonio ha luogo due settimane dopo l’uscita del primo libro, un matrimonio perfettamente solidale e felice che durerà trent’anni, fino alla morte di Zamenhof, e che sarà allietato da tre figli, dei quali due diventeranno medici e una diplomata giurista.
Un altro suggerimento che indicò a Zamenhof come possibile una lingua ausiliaria artificiale furono le lingue segrete che usavano i ragazzi a scuola. Tutti i giovani si sono divertiti o cimentati in simili giochi, peraltro quasi sempre immediatamente decifrabili. Altri più seri usavano un altro sistema scritto con un alfabeto segreto, o un codice nel quale alcune parole erano sostituite da altre. Si creava quindi un gergo segreto che però era parlato tranquillamente, dando ai ragazzi la soddisfazione di comunicare senza essere capiti dagli estranei.
In quel vastissimo territorio che era l’Impero Russo si erano create delle circostanze favorevoli per società segrete, religioni nascoste, per attività sotto il pavimento (come era l’espressione di allora). Contadini che si trasferivano, artigiani nomadi, membri di sette fuggitivi, mendicanti girovaghi, criminali politici in fuga (spesso idealisti innocenti) e adepti appassionati di mille eresie e sogni mistici, insieme a normali briganti, delinquenti e incapaci; tutte queste persone si muovevano a frotte e vagavano dal deserto dei Mongoli fino ai Carpazi, dal Mar Glaciale Artico all’India. Questo era il calderone sociale in cui bollivano tutti i dolori e le passioni, dove fermentavano tutte le fedi: tutti avevano bisogno di lingue segrete per sopravvivere; e poiché sopravvivevano, evidentemente avevano creato queste lingue segrete. In Europa occidentale queste lingue si sono formate principalmente in regioni a lingua mista, lungo le vie delle migrazioni degli artigiani. L’Impero Russo era proprio una regione mista, solo più vasta, e quindi ancora più favorevole per la fioritura di mezzi di comprensione artificiali. In questo sta il motivo di una profonda differenza tra i movimenti per una lingua mondiale sviluppatisi in occidente e quelli dell’oriente. Lingue uscite da persone del primo tipo erano prodotti senza anima di esimi professori, rispettosissimi del Latino come lingua internazionale. Il secondo tipo di lingue erano prodotti vitali del popolo stesso, che creava, e crea ancora adesso, espressioni linguistiche vive per le proprie necessità immediate. Zamenhof era del secondo tipo: per questo il suo senso linguistico era più forte di quello degli eruditi della civiltà occidentale l’istinto popolare e pieno di vita era ovviamente superiore alla pallida scienza degli intellettuali.53
3.3 La nuova lingua alla prova
Zamenhof asserisce, nella sua lettera a Schleyer, di aver conosciuto il Volapük soltanto quando era già avanti con il suo progetto; inoltre nei suoi scritti non vi è mai menzione di altri progetti precedenti, che tuttavia erano stati proposti in gran copia. Egli dice di essersi basato soltanto su lingue europee vive, e quindi, nella generale suddivisione che viene fatta dei progetti di lingua internazionale, tra lingue a priori, a posteriori e miste, l’esperanto è a posteriori, mentre il Volapük è tra le miste. Alcune singolari coincidenze con un esperimento precedente di lingua quasi del tutto a priori, la lingua pansofica di Comenius, che abbiamo già citato, sono da considerarsi assolutamente casuali; peraltro il manoscritto di Comenius era andato perduto alla sua morte e tornò alla luce soltanto nel 1935, per cui è da escludere che Zamenhof lo conoscesse.
Cosa c’era dunque di nuovo nel progetto che esce nel 1887 rispetto alle versioni precedenti, e anche rispetto al Volapük o ad altri progetti di lingua internazionale? Tre caratteristiche erano evidenti: in primo luogo la scelta delle radici e dei suffissi, presi principalmente dalle lingue neolatine e germaniche, ma anche in parte da lingue slave, rendeva la lingua veramente internazionale e facilmente comprensibile alle persone di cultura del mondo occidentale. Il principio della “comprensione immediata” era stato, e sarebbe stato ancor di più nei tentativi successivi, la pietra di paragone di molti progetti di lingua internazionale. Visto con gli occhi di oggi, era un principio errato. Ogni lingua ha la sua struttura e le sue potenzialità di evoluzione: la somiglianza con altre lingue è più di ostacolo che di aiuto nel suo sviluppo. Ma a quel tempo, quando lo scopo era principalmente la sua rapida diffusione tra i ceti colti, la facile riconoscibilità delle radici, anche senza studio, veniva ritenuta una caratteristica essenziale. Il Volapük, che pure era allora all’apice del suo successo, come abbiamo visto, mancava proprio di questa caratteristica: i pronomi personali erano semplici, ma forgiati arbitrariamente senza nessun legame con quelli di lingue conosciute; i verbi consentivano una precisione estrema, ma non necessaria, e quindi le loro numerosissime forme appesantivano la grammatica; i vocaboli erano deformati spesso nella loro parte iniziale, perdendo in riconoscibilità.
Una seconda caratteristica della Lingua Internazionale era che tutte le radici rimanevano fisse e tutte le distinzioni morfologiche erano espresse tramite elementi fonetici a sé stanti; le parole quindi consistevano soltanto dell’accostamento di quelle radici a quegli elementi fonetici. Tutta la lingua, dal punto di vista sia grammaticale che lessicale, si trovava nel vocabolario e quindi poteva essere capita anche da una persona che non l’avesse mai studiata, semplicemente cercando appunto nel vocabolario radici e desinenze. Una terza caratteristica era che la lingua, ancorché ispirata a elementi di lingue etniche, era pienamente autonoma ed aveva una sua individualità.
La riprova si ebbe nell’arco di pochi mesi. I primi cultori, che comperarono la grammatica in libera vendita in librerie e stazioni, erano principalmente polacchi e russi, in gran parte di etnia ebraica. Ma presto si aggiunsero numerosi tedeschi, spesso già adepti del Volapük. Il Secondo libro55 apparirà nel 1888, meno di un anno dopo, e sarà totalmente nella nuova lingua: un piccolo popolo esperantista si era già formato, molti interessati avevano scritto al Dr. Esperanto indicando la loro disponibilità ad imparare la lingua se altri lo avessero fatto, o dichiarando di averla già imparata rapidamente. C’è quindi già un pubblico di cultori della lingua internazionale, ai quali diventa del tutto naturale rivolgersi nella lingua stessa. Il Secondo libro contiene un commento a proposte di riforma della lingua pervenute all’autore, esercizi e frasi, e ancora brani letterari: una favola di Andersen, il Gaudeamus igitur e ancora una poesia di Heine, tradotta tuttavia non più dallo Zamenhof, ma da un poeta, giornalista e saggista polacco, l’ebreo Leo Belmont. Ci sono anche alcuni proverbi, altra colonna portante di una qualsiasi civiltà; lo Zamenhof vuole creare attraverso la traduzione di proverbi una tradizione linguistica, e a questa raccolta di pillole di saggezza resterà sempre affezionato. Ancora letteratura dunque, ancora brani di autori internazionalmente noti. Andersen viene tradotto non dall’originale (Zamenhof non conosceva il danese), ma dalla versione in tedesco. Ancora un riferimento centro-europeo; ancora un segno di supremazia della cultura tedesca. Nessuna traduzione dal russo. Con l’uscita nel 1888 del Primo libro anche in versione inglese60 si può considerare che il seme è gettato definitivamente anche ad occidente del Reno.
Con il 1889 la “Lingua Internazionale del dr. Esperanto” comincia ad essere chiamata semplicemente con lo pseudonimo del suo iniziatore, e gli adepti si chiameranno esperantisti61. I centri di diffusione sono a Varsavia, dove vivono Zamenhof e Belmont, a Odessa, a Uppsala, a Norimberga, dove, il 1° settembre 1889, inizia le pubblicazioni il primo giornale in esperanto, «La Esperantisto» (L’Esperantista), la cui testata recita: “rivista per gli amici della lingua Esperanto”. L’articolo di fondo è in tedesco, francese ed esperanto; il resto è in tedesco e in esperanto, e questo bilinguismo dura per tre numeri: a partire dal gennaio 1890 il tedesco è abbandonato. La cadenza, salvo che per il secondo numero che appare in dicembre, è mensile. I gruppi esperantisti che si formano sono spesso di adepti del Volapük che passano all’esperanto, lingua che appare loro molto più familiare. L’indirizzario dei primi mille adepti registra 919 nomi nell’impero russo, e questa proporzione si verifica anche tra gli abbonati alla rivista, che nel 1894 figurano essere poco meno di 600. «La Esperantisto» cesserà nel 1895: la censura imperiale vieterà l’ingresso del periodico nel territorio russo senza dare motivazioni (forse perché la rivista aveva pubblicato un articolo di Tolstoj, Saggezza e fede, non gradito alle autorità), e il numero degli abbonati fuori dell’impero è troppo esiguo per poter sostenere i costi. È questa la prima persecuzione nei confronti del movimento esperantista; purtroppo ben altre e ben più violente si avranno sotto vari regimi62. Ma solo dopo qualche mese nascerà ad Uppsala, in Svezia, una nuova rivista, «Lingvo Internacia» (Lingua Internazionale); come in una staffetta il testimone era passato al frazionista successivo. Il movimento si era dimostrato vitale.
Una panoramica delle idee elaborate da Zamenhof fino alla fine del secolo si ha nel suo corposo trattato Essenza e futuro dell’idea di una lingua internazionale, pubblicato sotto lo pseudonimo Unuel e letto, in versione ridotta, da Louis de Beaufront al congresso dell’Association Française por l’Avancement des Sciences a Parigi nel 190064. In esso Zamenhof esprime la tesi che una lingua per la comunicazione internazionale può essere soltanto artificiale, e propone anche delle strategie per il movimento che la sostiene. Egli infatti non prevede che l’intero mondo possa sottostare ad una lingua nazionale, per cui la scelta di una lingua non etnica si imporrebbe da sola. Dati i fallimenti dei tentativi precedenti, tale lingua non può essere che l’Esperanto, a cui, quando fosse necessario per l’adozione generale, potranno essere apportati dei cambiamenti. Tali cambiamenti, già rifiutati nel 1894 in una votazione dei lettori della rivista, saranno poi definitivamente rifiutati durante il primo congresso generale svoltosi nel 1905 a Boulogne-sur-Mer, una località francese sulla Manica. Il popolo esperantista ha acquisito una certa massa critica ed è diventato linguisticamente conservatore: non è più alla ricerca di miglioramenti continui che minerebbero la stabilità e l’utilizzabilità della lingua, ma vuole fruire dello strumento che è ritenuto ormai pienamente funzionante. Tre testi fondamentali, la grammatica, gli esercizi e il vocabolario sono presi come base immutabile e vengono fissati a costituire il Fundamento de Esperanto: la lingua diventa quindi stabile, e il popolo esperantofono si rivela obbediente. La maggioranza degli adepti, tra i quali pur si trovano molti fautori di riforme, sceglie di restare fedele alle forme linguistiche fissate da Zamenhof nel 1887: il Fundamento acquisisce l’autorità che nelle lingue etniche ha la tradizione. Partendo da tale base, l’esperanto si evolverà come una lingua naturale, con successive piccole modernizzazioni che interverranno nell’uso, senza autori o autorità che impongano dei cambiamenti. Viene istituita l’Accademia di Esperanto, un organismo deputato a mantenere l’unità della lingua, al pari di un’accademia linguistica nazionale.
4. Dopo Zamenhof
Per quanto possa sembrare un bisticcio, il principale successore di Zamenhof dal punto di vista dell’ideologia fu Zamenhof stesso. La sua idea di fratellanza universale era rimasta in secondo piano in quanto, mentre la componente linguistica stava avendo i suoi successi, la parte ideologica non incontrava la stessa larga condivisione. Il popolo esperantista nel primo congresso aveva rifiutato l’associazione della lingua ad una ideologia pacifista. Addirittura nel discorso inaugurale tenuto da Zamenhof, che si chiudeva con una poesia, il comitato organizzatore pregò lo Zamenhof di espungere l’ultima strofa, che diceva “cristiani, ebrei o maomettani, siamo tutti figli di Dio”. La fratellanza universale, che era stata un sottofondo, anche se non l’unico, della lingua universale e il suo maggiore stimolo, veniva posta in ombra, se non proprio apertamente rifiutata. Una associazione degli esperantisti che perseguisse una solidarietà tra gli adepti ebbe una fase di gestazione estremamente faticosa, e si concretò soltanto nel 1908.
Dal 1901 al 1914 Zamenhof scrisse vari opuscoli in russo e in esperanto, in cui predicava l’hillelismo, una dottrina di interpretazione della legge ebraica, praticata da Hillel, dottore e capo del collegio farisaico contemporaneo di Gesù, in cui viene data grande importanza all’amore per il prossimo. Dell’hillelismo Zamenhof fissa un certo numero di dogmi, di cui il primo, riguardante l’essenza della dottrina, dice:
L’hillelismo è una educazione, che, senza staccare l’uomo dalla sua patria naturale, né dalla sua lingua, né dalla sua religione, gli dà la possibilità di evitare ogni falsità e contraddizione nei suoi principi religiosi e nazionali e di comunicare con le persone di tutte le lingue e religioni su un fondamento umano neutrale, su principi di fratellanza reciproca, uguaglianza e giustizia.
Il dogma successivo fissa lo scopo finale:
Gli hillelisti sperano che tramite una comunicazione reciproca costante sulla base di una lingua neutrale e di principi e costumi religiosi neutrali gli uomini si fonderanno insieme in un popolo genericamente umano, ma questo avverrà a poco a poco, senza che ciò sia avvertito e senza alcuna rottura.
Zamenhof dunque considera la lingua come strumento della sua dottrina “assimilista”, ma la lingua percorrerà il suo cammino autonomo; tuttavia ancora adesso una non piccola parte di coloro che si avvicinano all’esperanto sono attratti proprio dall’idea di uguaglianza tra i popoli.
Sull’onda di un mancato accoglimento generalizzato dell’esperanto e guardando retrospettivamente la rapida caduta del Volapük, molti adepti dell’idea di lingua internazionale ritennero che il successo fosse mancato per carenze della lingua dal punto di vista tecnico. Vi fu quindi la rincorsa ai “miglioramenti”; in vista di una eventuale adozione da parte di organismi scientifici di prestigio internazionale. In particolare, in completa opposizione alle lingue filosofiche del secolo precedente, alcuni tesero fortemente al mito della “comprensibilità immediata”, possibile soltanto per chi conoscesse già alcune lingue europee. Il mancato successo su larga scala dell’esperanto era invece dovuto a ragioni politiche, non linguistiche; al contrario, si può ben a ragione dire che il suo successo, ancorché limitato, è dovuto a quella equilibrata mescolanza di semplicità della grammatica e di riconoscibilità del lessico, di libertà di costruzione e giusta dose di caratteristiche flessive in una lingua fondamentalmente agglutinante. Tale equilibrio non si è verificato per altri progetti, che a volte hanno voluto privilegiare troppo una caratteristica rispetto ad un’altra. E tuttavia è significativo che moltissimi progetti che si sono susseguiti sono semplicemente un esperanto più o meno modificato, dall’Ido all’Antido, dal Neo-Esperanto al Neo, dall’Esperanta al Nov-Esperanto, dall’Esperantido all’Esperanto simpligita e a moltissimi altri: numerosi autori hanno creduto che bastasse qualche ritocco per rendere la lingua maggiormente accetta al grande pubblico. Altri invece si sposteranno verso un naturalismo aderente alle lingue occidentali: avremo l’Occidental (E. von Wahl, 1922) che nel 1947 per motivi politici verrà ribattezzato come “Interlingue”, o il Novial (O. Jespersen, 1928), a metà tra l’Ido e l’Occidental. I continui mutamenti e tentativi di miglioramento hanno impedito a tutti questi progetti di prendere corpo in maniera significativa, mentre l’esperanto, reso stabile dall’aderenza al Fundamento, resisteva e si evolveva indisturbato.
Tra i numerosissimi elaboratori di altri progetti di lingua internazionale citiamo due logico-matematici: Giuseppe Peano e Louis Couturat. Essi ebbero un vivace carteggio che durò intenso per alcuni anni, e che è stato pubblicato molto recentemente; vi troviamo elementi interessanti su come l’idea di lingua internazionale avesse cultori di varia personalità e mette a fuoco un periodo particolarmente significativo per entrambi i matematici.
Giuseppe Peano (1858-1932) è professore ordinario di Analisi infinitesimale all’Università di Torino, ma i suoi interessi sono estremamente vasti; Alexandre Louis Couturat (1868-1914) è di dieci anni più giovane, ed è meno titolato: infatti è professore alla Facoltà di Lettere di Tolosa e di Caen, sedi assai meno prestigiose di quella di Torino, ma ha già al suo attivo numerose opere molto importanti sulla logica. Le espressioni di saluto nelle lettere di Couturat sono molto deferenti verso l’illustre maestro.
Questo carteggio è soltanto una parte dell’immensa opera epistolare del Peano. Ci restano di lui i carteggi con Cesaro, Amodeo, Giovanni Vacca, Pieri, Vitali, oltre che lettere sparse con Tarski, Berzolari, Tonelli, Enriques e altri. Simmetricamente, di Couturat, anch’egli molto prolifico nello scrivere lettere, c’è ancora poco di studiato sistematicamente: il suo carteggio con Russell e alcune lettere a Pieri e Vacca. Nel carteggio con Peano, che raccoglie 101 missive, quasi tutte in francese, conservato presso l’Archivio Peano della Biblioteca Civica di Cuneo e presso il Museo Civico di Cuneo, soltanto 4 sono di Peano, mentre le altre 97 sono di Couturat. L’epistolario tuttavia non è completo: le lettere di Peano pubblicate sono soltanto le sue minute (e infatti mancano del tutto gli usuali convenevoli, che probabilmente comparivano nella stesura definitiva), mentre gli originali sono purtroppo andati perduti. Le 101 missive sono quindi uno spaccato estremamente significativo, ma sono molte meno di tutte quelle intercorse tra i due matematici nel periodo studiato (1896-1914). Il volume ha in appendice altri quindici documenti legati alle tematiche del carteggio: lettere a Peano ad altri, lettere di Couturat ad altri e il commosso necrologio di Couturat, perito in un incidente automobilistico, scritto da Peano su Revista Universale.
Fino al 1899 i temi trattati nelle lettere riguardano la logica e il Formulaire che Peano aveva pubblicato, e del quale aveva in mente una significativa estensione. Esso si inquadrava nella sua idea, lungamente perseguita e in parte poi realizzata, di una scrittura fortemente formalizzata della matematica, in modo che questa disciplina, e in particolare la logica, fosse scrivibile in modo da essere compresa da tutti, indipendentemente dalla loro lingua. Con il 1900 si ha un accendersi dell’interesse per la lingua internazionale, e tale tema interviene fortemente nell’epistolario diventandone l’argomento principale e, in fondo, la causa dell’interruzione brusca dei rapporti tra i due protagonisti.
Entrambi sono dei forti propugnatori dell’idea di una lingua unica per la scienza, ed entrambi vedono la soluzione in una lingua pianificata (o “artificiale”, come si diceva allora) che non privilegi nessuna nazione. Entrambi hanno provato il Volapük e ne sono stati delusi, entrambi si sono avvicinati all’esperanto: il Couturat anzi ne fu uno dei più appassionati fautori fino allo scisma che portò alla creazione dell’Ido (1906-1908), mentre il Peano non si impegnò affatto nella propaganda dell’esperanto, che pure aveva rapidamente appreso, almeno a livello elementare. Una sua lunga lettera di risposta all’entusiasta esperantista Meray esprime i dubbi sulla rapidità di apprendimento di qualsiasi lingua ai fini di una conversazione, citando il fatto che anche l’italiano, insegnato da decenni, non è compreso nelle campagne dello stato italiano stesso. Nella diatriba tra i fautori delle diverse lingue internazionali Peano resta tiepido: non gli piacciono i fanatici, sia fautori dell’esperanto, sia Couturat stesso quando passa dall’esperanto all’ido; la scelta di questa o quella lingua internazionale diventa una questione di fede, e il passaggio da un progetto all’altro appare un tradimento. Gli idisti hanno l’estremismo entusiasta dei neofiti, gli esperantisti hanno già raggiunto un peso specifico tale da essere contrari a novità. Gli idisti accusano gli esperantisti di impedire il successo dell’idea con il loro conservatorismo linguistico, gli esperantisti accusano gli idisti di minare l’idea stessa di lingua internazionale con il loro desiderio di cambiamento che impedisce una stabilizzazione. Peano ha creato una lingua a sua volta, il latino sine flexione (1903): e quella usa nelle pubblicazioni, nei libri, nelle riviste. Il latino sine flexione è assai più rispondente sia dell’esperanto che dell’ido al principio della comprensibilità quasi immediata per i dotti che parlano una lingua neolatina; è invece fortemente perdente quando dovesse essere usato da parlanti di lingue di altro ceppo. Peano non insiste sull’unicità della lingua e nelle pubblicazioni della sua rivista, «Schola et vita», accoglie articoli scritti nelle varie lingue internazionali, lasciando che ciascuno usi quella che conosce; in realtà sono tutte simili, chi conosce il latino e l’esperanto legge senza difficoltà tutte le altre che nascono in quell’epoca.
Peano resta tuttavia nell’ambito dell’elite: egli si occupa della comunicazione tra scienziati o comunque tra persone colte, le quali, se pur non sanno più parlare il latino per la sua difficoltà di apprendimento, tuttavia ne conoscono teoricamente la grammatica. Basta allora togliere le faticose desinenze e sostituirle con preposizioni, come ha fatto la gran parte delle lingue neolatine nel corso della loro evoluzione. Couturat ha invece incontrato gli ideali del socialismo; il suo interesse per il problema della lingua internazionale dapprima aveva motivazioni teoriche, ma successivamente egli ne riconosce la rilevanza sociale e l’aspetto democratico di una comunicazione egualitaria. Couturat passa all’Ido, anzi ne è il segreto ideatore, rincorrendo una maggiore facilità. Ma l’Ido non decollerà e ancora dopo 100 anni ha un livello di diffusione molto più basso dell’esperanto. Couturat, convinto pacifista, muore nel 1914 il giorno dello scoppio della I guerra mondiale; la sua macchina si scontra con un’altra, quella degli staffettisti che portavano l’ordine di mobilitazione.
Come ultima considerazione possiamo notare che con la prima guerra mondiale cambiano totalmente i parametri secondo i quali è desiderabile una lingua ausiliaria per i contatti internazionali. Nascono in Europa nuovi stati, e numerose altre lingue che prima erano solo nazionali diventano statali. L’esperanto vive un momento di prosperità in Ungheria, Cecoslovacchia, in un primo tempo anche in Unione Sovietica. Ma poi i vari nazionalismi e sciovinismi, da quello sovietico a quello nazista, e, verso la fine degli anni Trenta, anche quello fascista, sono una minaccia concreta per le idee internazionaliste. Le varie associazioni esperantiste sono messe a tacere in Germania, si trovano in difficoltà in Giappone, vengono osteggiate in Italia. La seconda guerra opera un ulteriore rimescolamento, con cospicui spostamenti di popolazioni all’interno dell’Europa stessa e con una ascesa della potenza e dell’egemonia culturale, economica e militare degli Stati Uniti. L’attuale Unione Europea conta 60 idiomi con lo status ufficiale di “lingua”, ha uno specifico Commissario per la diversità linguistica che dovrebbe favorire la libertà di usare la propria lingua nell’ambito delle istituzioni europee; contraddittoriamente invece l’UE offre posti di lavoro soltanto a conoscitori nativi di alcune lingue, principalmente l’inglese, e richiede che i documenti ufficiali degli stati che chiedono l’adesione all’UE siano solo in inglese. Il concetto di democrazia linguistica e di uguaglianza tra i popoli come era inteso alla fine dell’Ottocento ha subito modificazioni notevoli, che meritano uno studio approfondito.
E oggi? Quale è la situazione dell’esperanto? Numerose attività e pubblicazioni ne confermano il suo successo limitato, ma che perdura68. Citiamo qui solo l’ultimo evento di portata mondiale svoltosi in Italia. A fine luglio 2006 si è svolto, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, il 91° Congresso Mondiale di Esperanto, a cui hanno partecipato circa 2200 delegati da tutti i continenti. Molti enti e personalità italiane, da Moni Ovadia ad Andrea Bocelli, dal linguista Tullio De Mauro al presidente dell’Accademia della Crusca Francesco Sabatini, figurano nel comitato d’onore. Il giorno prima dell’inaugurazione del congresso l’Accademia della Crusca, in collaborazione con l’Accademia di Esperanto, con l’Accademia Internazionale delle Scienze San Marino e con l’Università di Firenze ha organizzato un convegno su Bruno Migliorini, con conferenze in italiano e in esperanto sull’attività del grande linguista. Al congresso sono stati presentati gli ultimi tre capolavori della letteratura italiana in versione esperanto: I promessi sposi, Il Principe, I Malavoglia. Successivamente è uscita la traduzione in terza rima della Divina Commedia, e come omaggio alla sede che ci ospita, ne proponiamo gli ultimi versi:
Kiel la geometro sin koncentras
al cirkla kvadratur’ kaj ne elvokas
tiun principon, kiun li ne centras,
tiel la nova vido nun min ŝokas:
scivolis mi, kiel la bildo venis
al tiu rond’ kaj kiel ĝi sin lokas.
Por tio miaj plumoj ne konvenis:
subite mian menson dum la provo
bategis fulmo, kaj la vol’ ekplenis.
Al mia fantazio mankis povo:
sed turnis min strebantan al ĉi celoj,
kiel la radon en egala movo,
Amo, movanto de la sun’ kaj steloj
![]() Umberto Eco, con il suo opuscolo dallo stile abbastanza pedestre “Il complotto” ha dato autorevole crisma ai pappagalleggianti che stigmatizzano con alquanto disprezzo i complottisti, che sarebbero quelli che vedono inesistenti intrighi a danno del popolo da parte di elite dominanti. Un pasticcio linguistico, accolto con prosit dai qualunque bevitori.
Umberto Eco, con il suo opuscolo dallo stile abbastanza pedestre “Il complotto” ha dato autorevole crisma ai pappagalleggianti che stigmatizzano con alquanto disprezzo i complottisti, che sarebbero quelli che vedono inesistenti intrighi a danno del popolo da parte di elite dominanti. Un pasticcio linguistico, accolto con prosit dai qualunque bevitori.